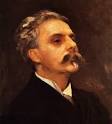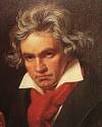Analisi dei meccanismi di
rottura del monumento eseguiti dall’Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle
ricerche, attraverso esperimenti a
piccola scala in centrifuga. I danni sono relativi all’inclinazione della
statua. La ricerca è pubblicata sul Journal of Cultural Heritage
A causa del suo inestimabile valore il David di Michelangelo, uno dei simboli del Rinascimento italiano, è stato oggetto di molte analisi di stabilità rivolte in particolare a una serie di micro-fratture della porzione inferiore di entrambe le gambe, notate già dalla metà del XIX secolo. Visibili nella caviglia sinistra e nel tronco destro, minacciano la stabilità dell'opera e quindi una loro approfondita conoscenza è indispensabile per la salvaguardia di questo capolavoro.
Un gruppo di ricercatori dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle ricerche (Igg-Cnr) e dell’Università degli Studi di Firenze ha eseguito un approccio sperimentale su repliche in gesso della statua a scala ridotta (10 cm di altezza invece di 410), deformate all'interno di una centrifuga. I risultati sono pubblicati sul Journal of Cultural Heritage.
“Durante la rotazione all'interno dell'apparato, i modelli a piccola scala sono sottoposti a forze molto più elevate della forza di gravità, ma che agiscono con le stesse modalità”, spiega Giacomo Corti dell’Igg-Cnr. “In differenti prove, le piccole statue sono state sottoposte a una forza centrifuga crescente, rendendo la statua sempre più ‘pesante’, finché gli sforzi gravitazionali superano la resistenza del materiale e si giunge alla rottura”.
Gli esperimenti hanno analizzato l'influenza di vari parametri. “In particolare, i risultati suggeriscono come sia la stabilità sia le caratteristiche della deformazione del David siano principalmente dovute all'inclinazione della statua. Innanzitutto, maggiore è l'angolo di inclinazione, maggiore è l'instabilità della statua sotto il proprio peso, particolarmente per inclinazioni maggiori di 15°. Inoltre, l'inclinazione influenza anche la posizione delle fratture, che tendono a interessare porzioni via via più alte: nella gamba destra, sopra i 15° la frattura avviene sempre al di sopra del tronco d'albero”, prosegue il ricercatore.
La comparazione di questi risultati con le lesioni rilevate sul David reale suggeriscono che “una costante inclinazione della statua, ancorché non superiore a 5°, abbia rappresentato il fattore critico per lo sviluppo dei sistemi di fratture nelle porzioni inferiori di entrambe le gambe”, conclude Corti. “Questa piccola inclinazione è probabilmente legata all'abbassamento non uniforme, con conseguente piccola rotazione del plinto su cui poggia la statua, durante la sua permanenza di fronte a Palazzo Vecchio, tra il 1504 e il 1873”.
A causa del suo inestimabile valore il David di Michelangelo, uno dei simboli del Rinascimento italiano, è stato oggetto di molte analisi di stabilità rivolte in particolare a una serie di micro-fratture della porzione inferiore di entrambe le gambe, notate già dalla metà del XIX secolo. Visibili nella caviglia sinistra e nel tronco destro, minacciano la stabilità dell'opera e quindi una loro approfondita conoscenza è indispensabile per la salvaguardia di questo capolavoro.
Un gruppo di ricercatori dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle ricerche (Igg-Cnr) e dell’Università degli Studi di Firenze ha eseguito un approccio sperimentale su repliche in gesso della statua a scala ridotta (10 cm di altezza invece di 410), deformate all'interno di una centrifuga. I risultati sono pubblicati sul Journal of Cultural Heritage.
“Durante la rotazione all'interno dell'apparato, i modelli a piccola scala sono sottoposti a forze molto più elevate della forza di gravità, ma che agiscono con le stesse modalità”, spiega Giacomo Corti dell’Igg-Cnr. “In differenti prove, le piccole statue sono state sottoposte a una forza centrifuga crescente, rendendo la statua sempre più ‘pesante’, finché gli sforzi gravitazionali superano la resistenza del materiale e si giunge alla rottura”.
Gli esperimenti hanno analizzato l'influenza di vari parametri. “In particolare, i risultati suggeriscono come sia la stabilità sia le caratteristiche della deformazione del David siano principalmente dovute all'inclinazione della statua. Innanzitutto, maggiore è l'angolo di inclinazione, maggiore è l'instabilità della statua sotto il proprio peso, particolarmente per inclinazioni maggiori di 15°. Inoltre, l'inclinazione influenza anche la posizione delle fratture, che tendono a interessare porzioni via via più alte: nella gamba destra, sopra i 15° la frattura avviene sempre al di sopra del tronco d'albero”, prosegue il ricercatore.
La comparazione di questi risultati con le lesioni rilevate sul David reale suggeriscono che “una costante inclinazione della statua, ancorché non superiore a 5°, abbia rappresentato il fattore critico per lo sviluppo dei sistemi di fratture nelle porzioni inferiori di entrambe le gambe”, conclude Corti. “Questa piccola inclinazione è probabilmente legata all'abbassamento non uniforme, con conseguente piccola rotazione del plinto su cui poggia la statua, durante la sua permanenza di fronte a Palazzo Vecchio, tra il 1504 e il 1873”.